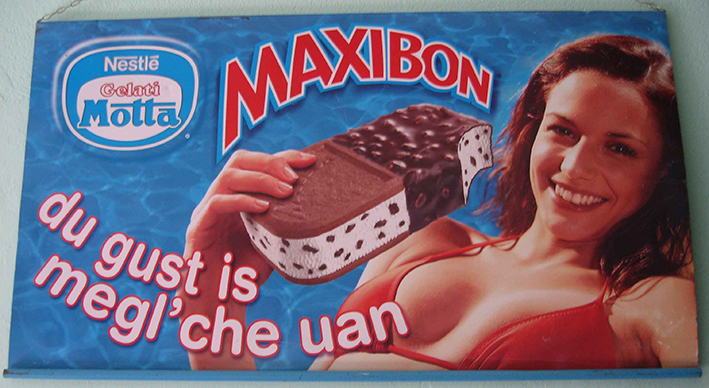Molti ragazzi adottati sono un enigma per le loro famiglie. Le difficoltà comunicative dipendono in larga parte da un malinteso di base, ossia che l’adozione sia – a priori – una grande fortuna, per la quale gli adottati dovrebbero essere grati. La cosa é certamente vera, ma questi individui sono spesso troppo sofferenti per poterlo ammettere (anzitutto a sé stessi), e soprattutto troppo in colpa verso la famiglia naturale, per poter amare senza riserve i genitori adottivi.
Mi Tierra
Il senso di colpa, nel bambino adottato, è quanto di più indicibile, e, al contempo, divisivo, possa esserci, all’interno dei nuovi equilibri familiari. La psicoanalisi ci ha mostrato come gran parte della nostra crescita come individui avvenga attraverso un’identificazione inconsapevole con i genitori (o i care giver), ossia con i loro sogni, desideri, passioni ecc… . Ed è così, per esempio, che ciascuno di noi tifa per una squadra di calcio, o ama un certo artista, forse proprio perché ne ha sentito parlare in casa da bambino. Questa dinamica è presente un po’ in tutti noi, non c’è da stupirsi, e in genere dura fino a quando, con l’adolescenza, non diventino più importanti i gusti, e le opinioni, del gruppo di pari. Anche il bambino adottato è pervaso dei sogni, delle ambizioni, dei desideri della sua famiglia naturale, (o che suppone siano), per questo fatica ad acquisire quelli della nuova famiglia. Ma c’è di più. Dal momento in cui viene accolto in un contesto, che, per esempio, è più ricco, o ha un’istruzione più alta, non raramente nel suo profondo comincia a covare un certo senso di colpa. Il bambino si ripete domande del tipo: “Ma davvero me lo merito?”, “Non avrei dovuto restare, e aiutare i miei familiari?”. Oppure può cominciare a intraprendere condotte fortemente in contrasto con i valori della famiglia adottiva, ma comunque consonanti con quelli dei genitori naturali.
Un esempio concreto è quello dei tanti bambini provenienti dall’Europa dell’est, dal sud America o dall’estremo oriente. In Italia sono stati accolti da famiglie amorevoli, animate da valori positivi, ma, verosimilmente, valori in contrasto con quelli delle famiglie di provenienza. E infatti non è raro sentire storie di ragazzi che mantengono un legame viscerale con il loro passato, un legame nutrito proprio dal senso di colpa per avere accettato le lusinghe di una vita più agevole, e di aver abbandonato chi stava peggio. Per questo senso di colpa, come dicevamo, la famiglia adottante non è minimamente preparata. È semplicemente inimmaginabile – anzi – che un bambino possa avere delle remore a lasciare una situazione di svantaggio per una migliore. Ed è per questo, invece, che tutta la sofferenza causata da questo cortocircuito resta solitamente inespressa, non accolta.
Laddove i bambini non sanno nulla dei loro genitori naturali, poi, in realtà sentono, percepiscono, dal clima che li circonda, un certo pregiudizio, una specie di pretesa superiorità. Ecco, quindi, che alcuni possano covare nel profondo una specie di identificazione con quella cultura, quei valori, a scapito di quelli proposti dai nuovi genitori.
Distruggere: una missione
Una reazione al senso di colpa può essere il rigetto. La polemica aperta, le condotte in contrasto con i valori degli adottanti, la strenua difesa del diritto a “farmi una mia vita, perché voi non mi capite”, sfociano, talvolta, in una tendenza a fagocitare e distruggere. Autolesionismo, tossicodipendenza, aggressività verbale e fisica, sono alcune delle modalità in cui si può declinare una tendenza a sminuire, denigrare, danneggiare, rompere. Se il bambino adottato sente colpa per aver lasciato i Suoi, il nuovo papà non sarà mai abbastanza bravo, la nuova mamma non sarà mai sufficientemente buona, la nuova casa mai realmente accogliente.
E così nascono piccoli/grandi sabotaggi. Polemiche, dispetti, furti in casa: tutto quello che, in qualche modo, può svilire, allontanare, desacralizzare. Distruggere, potremmo dire, diventa quasi una missione, il cui scopo è condurre l’adozione al punto più basso possibile. Ossia a quel punto in cui le due parti, esauste, arriveranno, prima o poi, a dire: “ma chi ce l’ha fatto fare?”.