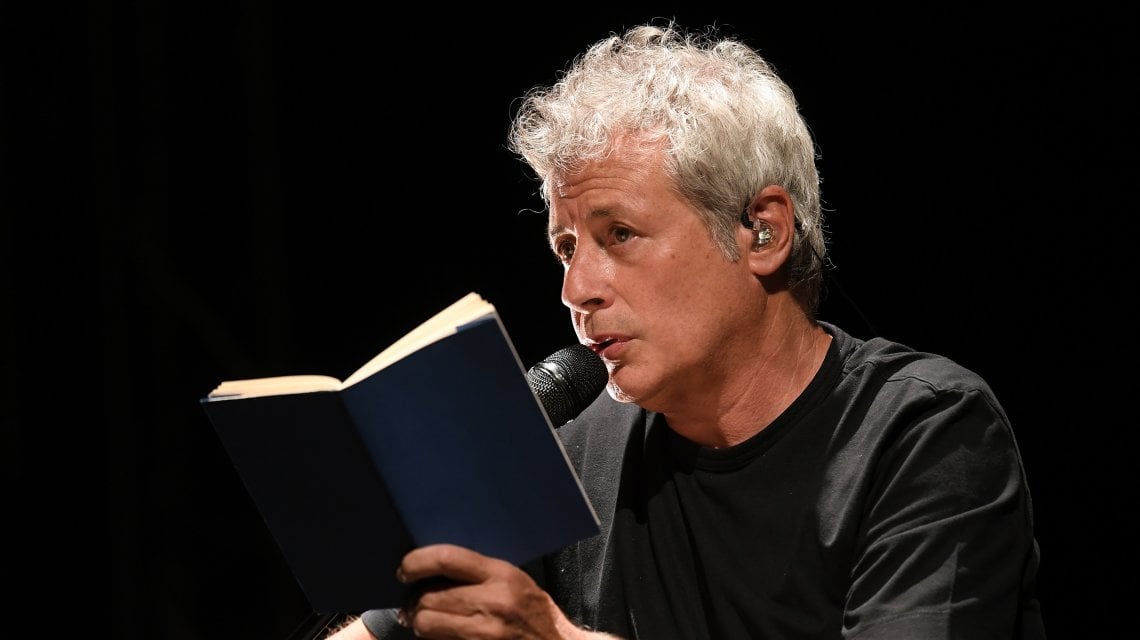L’ultimo brano dei Beatles – Now and then – dissolve il rapporto che lega l’opera d’arte con la rappresentazione del tempo. Ci appare, infatti, come un lavoro sospeso tra le epoche che lo segnano, e che utilizza la musica, che è tempo, per confondere i riferimenti temporali agli ascoltatori.
Il tempo della creazione
Per Umberto Eco la creazione di un’opera d’arte, la sua fruizione, e la sua conservazione, sono inestricabilmente connessi con il problema del tempo. Con Now and then i Beatles sfasciano tutti i riferimenti classici che legano un’opera con il tempo, e ci consegnano un lavoro che è insieme una grande illusione psichedelica, un monumento alla civiltà virtuale, una seduta psicanalitica in libere associazioni.
Partiamo dalla creazione. Tutti sappiamo che Dante ha lavorato una ventina di anni per la sua divina trilogia, che Tolstoj ne ha impiegati almeno dieci per Guerra e Pace, mentre Haydn, che era molto creativo, chiudeva i suoi lavori più velocemente. In questi casi il rapporto temporale tra l’ispirazione creativa e il prodotto finale appare abbastanza chiaro, ed è, infatti, legittimo chiedersi quanto abbiano impiegato quegli artisti per concretizzare la loro prima idea. Le cose si complicano quando parliamo di Eyes Wide Shut di Kubrick, o della Sagrada Familia di Gaudì, perché sono state, o verranno, terminate da altri. Indagare i tempi creativi è più arduo, perché può sempre restare il dubbio che siano opere diverse da come immaginate dall’autore. Il percorso artistico, in ogni caso, ci resta chiaro.
Dalla gestazione alla nascita di Now and then, invece, la cronologia biologica evapora. John Lennon ha registrato la demo nel 1977, ma da allora sono intervenuti tali e tanti accidenti, da rendere impossibile collegare il contenuto di quel nastro con il file pubblicato dai social network il 2 novembre 2023.
Guardiamo da più vicino. Nel 1995, storica reunion, i restanti ragazzi di Liverpool lavorano su alcuni brani che Lennon aveva lasciato su un nastro, tra cui Now and then. I tre pubblicano due tracce, lo sappiamo bene, ma scartano la terza, quella in questione: la voce di John è impastata al pianoforte, il risultato non li convince. Di quelle sessioni, tuttavia, restano arpeggi, accordi, giri di basso, di cui i tre non si disfano. Sono, quelle sessioni, da inserire nel tempo della creazione di Now and then? E se sì, stiamo parlando ancora del brano concepito da John, o di un’altra cosa, sospesa tra passato e futuro?
Inoltre c’è un passaggio intermedio, tutt’altro che trascurabile. Sulla cassetta con le incisioni c’era scritto “per Paul”, ma Lennon non l’ha mai inviata all’amico. È stata Yoko Ono a dare la cassetta a Macca, mesi dopo la morte di John. Quindi vediamo un po’, Yoko Ono un giorno nel Dakota Building apre un cassetto, trova il nastro, legge che è per Paul McCartney. Cosa fa la vedova Lennon? Se seguisse il suo primo istinto, alla vista di quel nome andrebbe su tutte le furie, distruggerebbe il tutto e buonanotte al secchio. Invece no, Yoko ha un sussulto, si morde le labbra, apre la porta ai fantasmi del passato. Lascia passare un po’ di tempo, Yoko Ono, e alla fine telefona a Paul.
Senza considerare che il nastro poteva tranquillamente andare perso, il rovello interiore di Yoko Ono, e il suo gesto, entrano di diritto nel tempo della creazione. Anzi, dovremmo ammettere che lo dissolvono: perché senza quella fase il brano non avrebbe mai visto la luce. La scelta di Yoko, dunque, si pone al di fuori delle consuete tempistiche creative, le supera, anzi le sfalda.
Veniamo a tempi più recenti, é il 2022: Paul McCartney e il suo team hanno nuovi programmi informatici, sentono che il lavoro non è ancora finito, tornano sulla vecchia traccia. Con l’intelligenza artificiale riescono a isolare dal pianoforte la voce di Lennon, “crystal clear” dice sir Paul incredulo: il problema del ’95 è superato! Si riapre il cantiere, ma nel frattempo Harrison non c’è più. Poco male, ci sono i video del ’95, gli arpeggi, gli accordi. Ci sono i disegni di George, la moglie è d’accordo, andranno bene per la copertina. Il basso si può risuonare, Ringo è un mago nei cori, e poi c’è la stoffa, tanta: e così sarà Paul a fare un assolo di chitarra, in stile George Harrison. Eh, quanta confusione! Il lavoro è finito, osserviamo meglio: la voce è di Lennon, ma il brano c’è per volere di Yoko, c’è grazie all’AI che separa le tracce, e grazie al fatto che nel trambusto dell’otto dicembre non è andato perso. Harrison c’è grazie ai video del ’95, grazie ai disegni dati dalla moglie, e grazie al talento di Paul. Quando esce il singolo è il giorno dei morti, e non è a caso: Now and then arriva dall’al di là, più che dal di qua. Per questo possiamo davvero dire che che è un brano senza tempo: è impossibile ricomporre le fasi della sua creazione, se non dicendo che è appunto il Tempo, nel suo insieme, che ce lo ha consegnato.
Il tempo della lettura e dell’interpretazione
Ammetterete che leggere un meme su Instagram sia più veloce che leggere La Repubblica di Platone. E anche la sua decifrazione, con tutto il rispetto, è più immediata. Now and then scioglie il concetto di tempo di lettura e di interpretazione di un’opera d’arte. Ci avevano già provato con Get Back, I Beatles, l’ultimo brano dell’ultimo album (della prima fase). Già in quel caso non erano tanto Jo Jo e Loretta Martin a dover tornare indietro, ma l’intero popolo beatlesiano. In un eterno ritorno alle radici, in un perpetuo vagabondare tra le pieghe del tempo passato, ritornare ai 16 anni di I saw her standing there era negare, insieme alla fine del gruppo, la fine dell’adolescenza. È così per ciascuno di noi, che giunto ai trent’anni, per la prima volta, ripensa ad un tempo passato.
Ma ora è diverso, Now and then dura pochi minuti, ma non finisce con l’inchino dei quattro. Anzi, è proprio allora che i fans asciugano la lacrima, afferrano la chitarra, e premono rec sullo smartphone. Oggi ci sono i social, tutto si può condividere. La storia dei Beatles si intreccia con la storia dei loro fans, con la storia delle loro emozioni, dei loro amori, delle loro delusioni.
Questa volta l’ascolto e l’interpretazione di una traccia audio non avrà fine. Ogni ascolto indurrà l’ascolto di altri brani, e la sua interpretazione porterà a fare confronti, discussioni, parallelismi. Come avviene con il testo freudiano in psicoanalisi, con la Critica della ragione di Kant, con la poesia romantica inglese. Now and then polverizza il rapporto classico tra l’arte e il tempo.
Now and then: ma quando di preciso?
“C’era una volta, tanto tempo fa…” così iniziavano le fiabe. La letteratura definisce il tempo narrativo in vari modi, a volte più esplicitamente, a volte meno, ma in genere sempre con un decorso lineare. Il principe Andreij ama segretamente Natasha, ai tempi delle guerre napoleoniche, il matrimonio di Renzo e Lucia non s’ha da fare, ai tempi della peste, Pisa è vituperio delle genti italiche, ai tempi del conte Ugolino. Che fosse una volta tanto tempo fa, senza altre indicazioni, o che fosse precisamente ai tempi di Napoleone, di don Abbondio o di Dante, la storia che viene raccontata ha un prima, un durante, un dopo. Al più, come in alcuni film gialli, potrà raccontare uno o più flash back, ma sempre all’interno di un frammento spazio-temporale definito.
Now and then è una matassa intricata di memorie, che definisce la dissoluzione del tempo narrativo e interpretativo. Lennon canta nel 1977, quindi si riferisce in maniera assai vaga a qualcosa che riguarda quegli anni. Ma si rivolge a Yoko Ono, o a Paul McCartney? Perché se si riferisce a Yoko, (il loro incontro risale al 1966), il Now and then riguarda gli anni tra il 1977 e il 1966. Se invece si riferisce a Paul, amico di infanzia, il riferimento si sposta a molto tempo prima. Oppure in un verso accenna a Stuart Suttcliff, l’amico morto prima del grande successo? In quel caso Now and then definirebbe un frammento di storia precedente all’incontro con Yoko, ma successivo a quello con Paul.
Come abbiamo detto, inoltre, il brano non esiste per solo merito di Lennon, quindi in quel “Now and then” vanno considerati gli accidenti del 1980, del 1981 (il ritrovamento), e del 1995. Ossia accidenti che riguardano la traccia che ascoltiamo, ma non gli intenti di chi la canta. Non esistono le coordinate spazio-temporali di Now and then.
E poi ci siamo noi, il pubblico. Anche noi, ascoltando, pensiamo al nostro “Now and then”: ma quand’è di preciso? Dante esce dalla selva a 35 anni, e noi con lui, pensiamo a quando, più o meno alla stessa età, ci volgemmo a rimirar lo passo che non lasciò persona viva. Quando Bastian si chiude nella soffitta della scuola, con la testa tra il mondo di Fantàsia e la principessa dei suoi sogni, lui (e noi) ha tra i 12 e i 16 anni. Quando Kid Rock canta Sweet home Alabama, a metà strada tra ragazzo e uomo, sappiamo bene cosa intende. Ma Now and then, quando la situiamo? Oggi che ascoltiamo, oppure quella volta che ci siamo innamorati? Oppure forse pensiamo a quando eravamo bambini, o a quando abbiamo visto per l’ultima volta colui che non ritorna, e ci manca così tanto?
Se non sappiamo rispondere a queste domande, o meglio se ogni volta a queste domande sorge una risposta diversa, significa che il tempo non viene più rappresentato, ma resta sospeso, come nella memoria. E che cosa fa sì che nella memoria un ricordo sia più vivido di un altro? Il connotato emotivo che vi si associa. Ecco allora che la rappresentazione del tempo perde i connotati narrativi, razionali, esteriori, che ha sempre avuto nell’arte, e ne acquisisce di differenti. Ed ecco l’ennesima magia di John Lennon, che ci lascia un brano fuori dal tempo, che è insieme grande illusione psichedelica, monumento alla civiltà virtuale, seduta psicanalitica in libere associazioni.