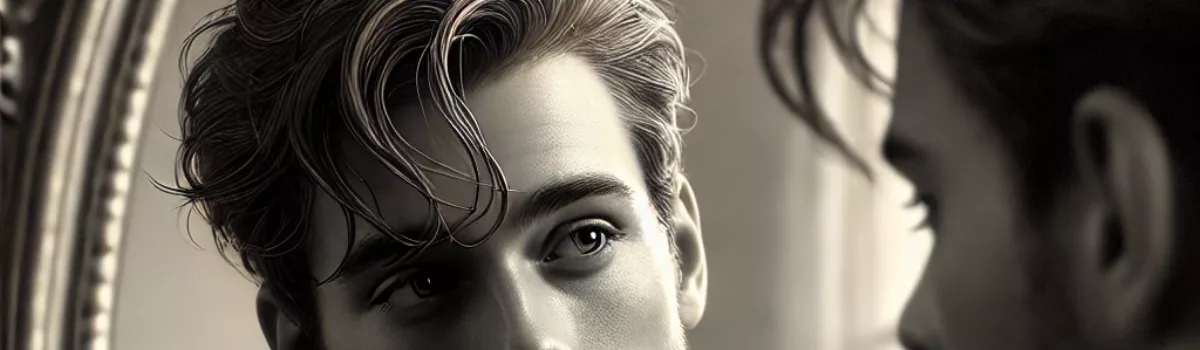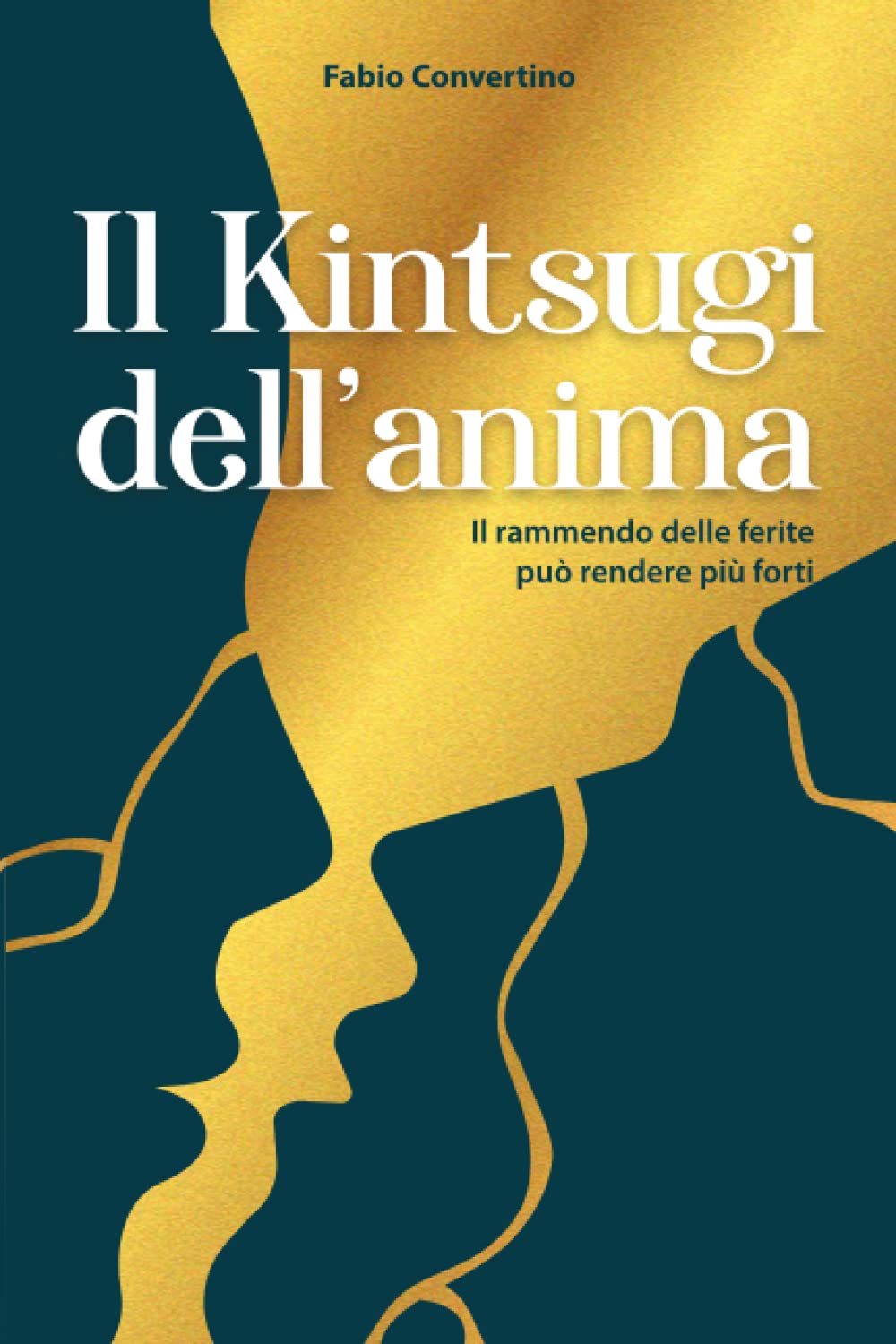Il perdono è uno dei capisaldi della nostra tradizione religiosa, cosa che si riverbera anche nel diritto, in cui per un condannato sono previsti sconti di pena, indulto, riabilitazione penale, ecc… . Abbiamo la tendenza, tuttavia, a considerare il perdono più come una cosa che gli altri debbano a noi, che come un movimento da parte nostra verso chi ci ha mancato di rispetto.
Il perdono di Dio e dello Stato
Dio pedona… io no! Questo titolo di un film dell’amata coppia Bud Spencer e Terence Hill, è molto eloquente nel discorso che stiamo facendo. Il Cattolicesimo è spesso ritenuta la religione del peccato. A torto, a mio avviso, perché più che in altre confessioni, o quantomeno in maniera diversa, ruota attorno al concetto di perdono. Dio perdona chi si rimette nelle sue mani, tramite le modalità previste dalla teologia. Non spetta ai teologi sindacare, non è nel potere dei fedeli contrattare. Il perdono di Dio fa parte della nostra storia religiosa e culturale, al punto che nessuno se ne sente offeso, o ne tenta una qualche forma di revisione.
Anche lo Stato perdona, in tutto o in parte, chi ha commesso dei reati contro la legge, e anche in questo caso nessuno, in genere, mostra risentimento. Anzi, chi ha fatto un reato è sovente portato a credere che il diritto non faccia abbastanza, che dovrebbe perdonare di più, che le pene sono troppo severe, ecc… . Il perdono verso di noi, in altre parole, non è mai troppo, non è mai a sproposito, anzi è sempre meritatissimo. Anche nelle forme più alte di errore, come quelle del peccato nei confronti di Dio, o di reato verso la legge dello Stato.
Lo stesso vale per le offese che rechiamo ad amici, conoscenti, colleghi, partner, e via dicendo. Il credito che riteniamo di avere è pressoché illimitato, sono sempre gli altri a dover fare uno sforzo, venirci incontro, apprezzare i nostri passi verso di loro.
Io perdono, ma non dimentico
Il discorso cambia, e di parecchio, quando siamo noi a dover perdonare per un torto subito. In questi casi, la cosa migliore che si possa sentire è: “Io perdono, ma non dimentico.” Che poi è un modo per dire che non se ne parla proprio. Perché questa disparità di posizione? Perché perdoniamo in quantità minore, e più faticosamente, di quanto vorremmo essere perdonati? Va detto che un’eccessiva predisposizione al perdono, soprattutto nell’ambito della vita di coppia, può talvolta risultare sospetta. Se perdoniamo con leggerezza un partner fedifrago, ad esempio, possiamo dare l’idea di non tenerci abbastanza, oppure di avere qualcosa da nascondere, oppure ancora di essere troppo dipendenti, e accettare qualunque compromesso pur di non perdere la relazione. Tuttavia il perdono non riguarda solo il tradimento in coppia, e dobbiamo ammettere che, in generale, perdonare è più difficile che chiedere, o aspettarsi, il perdono.
Per quanto pacifica, la cosa è talmente paradossale, che merita una piccola riflessione. Anzitutto, chi ci ferisce, lo fa in buona o cattiva fede? E poi, poteva fare diversamente? Avrebbe saputo resistere? Ha seguito se stesso, il suo istinto, oppure no? Queste domande, e altre simili che queste ci suscitano, ci portano in una direzione. Quanto è veramente responsabile chi ci offende con il suo comportamento?
Sul perdono, e la difficoltà di perdonare, partirei anzitutto da noi stessi, da cosa avremmo fatto noi al posto dell’altro, e da come vorremmo essere trattati, per giungere poi ad un’altra conclusione. Il perdono, è utile ricordare (Lacan, Kristeva), non si riferisce all’offesa, o al reato, ma alla persona: è un atto relativo all’altro. Non riguarda il furto, l’aggressione o la rapina, ma l’individuo che li ha commessi. Così in coppia, non perdoniamo il tradimento, ma chi lo ha fatto.
Il per-dono è un dono a noi stessi
Inoltre, il perdono libera il futuro. Restare ancorati all’evento che ci ha feriti, che è comunque passato, vuol dire non ripartire. Ecco, allora, la conclusione cui volevo giungere: il per-dono all’altro, sostanzialmente, è un dono fatto a noi stessi. Chiudere quella porta, è autorizzarci a guardare oltre, ad andare avanti. È allora forse questa la difficoltà? Restare fermi al torto subito è uno stop forzato, un drammatico alibi per non continuare a crescere senza l’altra persona.
Sta forse qui la ragione per cui vorremmo che, invece, a parti invertite, ci perdonassero tutto? Non riusciamo a capire per quale motivo si ostinino a non ripartire, quando è tutto chiaro, quando tutto è superato, quando ormai tutto è inesorabilmente chiuso nel passato?