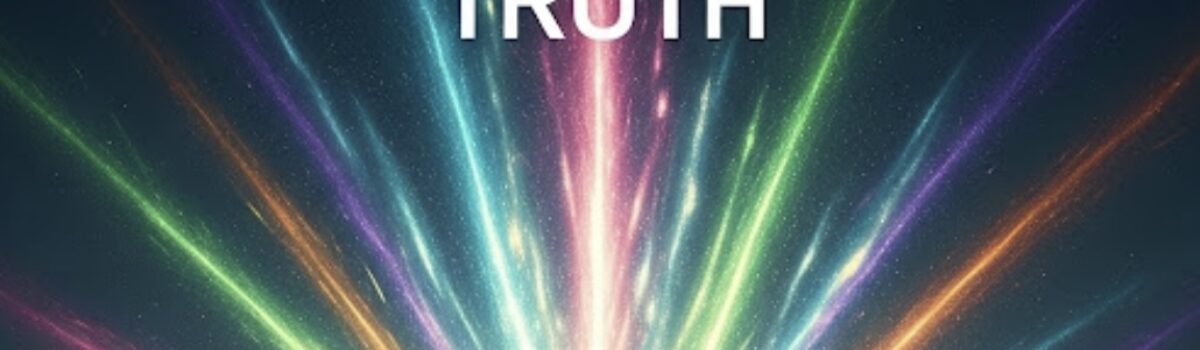Come già osservato a più riprese, attraversiamo una fase di decostruzione della verità e del senso dell’essere. La cosa investe anche psicologicamente il soggetto contemporaneo, e non solo nella sua azione pubblica, ma anche nella sua dimensione privata. La conseguenza di questa polverizzazione del vero e del riconoscibile, è una frammentazione della nostra soggettualità. Registriamo quotidianamente da un lato una diffusione esponenziale della patologia mentale, anche grave, da un altro il ricorso smisurato a sostanze stupefacenti o alcolici, da un altro ancora alla disperata ricerca di punti fermi su cui costruire, o ridefinire, la nostra identità, come ad esempio quello della squadra di calcio o del luogo di nascita. Proprio quest’ultimo punto diventa, oltrepassata una certa “normale tollerabilità”, addirittura paradossale, se è vero che lo stesso Dante Alighieri affermava di avere per patria il mondo.
Thruth!
Il presidente americano Donal J. Trump ha fondato, nel 2022, un proprio social network, a cui ha dato nome Truth, verità. Posto che un presidente degli Stati Uniti sia di per sé una voce autorevole, e per alcuni dovrebbe comunque dire sempre la verità, il fatto che abbia chiamato “Verità” un social network, la dice lunga sul rapporto che abbiamo sviluppato con questo concetto, già di per sé indefinibile. Perché se un presidente afferma di dire la verità sul suo social, verrebbe da chiedergli: quante verità pensi che esistano? Nel mondo le verità sono tante, siamo d’accordo, ma dovrebbe andare da sé che per ciascuno di noi ce ne sia una sola, ed evidentemente non è così.
La mia generazione ha studiato sui libri di Gianni Vattimo e Umberto Eco, ai tempi del pensiero debole, del post modernismo, e del crepuscolo della verità. Ora, dobbiamo ammettere che il crepuscolo è stato superato da un pezzo, e ai giorni nostri sulla verità è calata ampiamente la notte. Più della formula di Bauman “società liquida”, quindi, credo dovremmo dotarci del concetto di “frammentazione”. Il mondo è in via di frammentazione, e con lui lo è anche la nostra identità, sulla scorta di quel meccanismo che la psicoanalisi ha individuato come reazione al trauma e al traumatico.
Se pensiamo alla politica internazionale, siamo praticamente privi di punti di riferimento, diversamente, ad esempio, dagli anni della Guerra Fredda. All’epoca stavi con gli Stati Uniti o con l’Unione Sovietica, le due cose si escludevano a vicenda, generando conseguenze. Soprattutto, questa dicotomia ti aiutava a definirti, a fissare la tua identità. Poi è crollato il Comunismo, e in Italia, ad esempio, è arrivato Berlusconi. Non ci siamo più divisi più tra capitalisti e socialisti, ma eravamo comunque divisi tra pro e contro il Cavaliere, e insomma, anche lì la politica ci aiutava a fare una “scelta di campo”, a compattare la nostra identità.
Oggi la politica si è frammentata, a livello internazionale come locale, ed è difficile prendere una posizione netta e definitiva. Anzi, è diventato molto facile cambiare partito, o anche schieramento. La frammentazione ha investito la Policy, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Anche l’economia si è fortemente frammentata. Le classi sociali non esistono più nei termini di qualche anno fa, economicamente gli italiani sembrano essere scivolati in un incubo alla Stephen King, da cui nessuno riesce a svegliarli. E così, a ruota, la frammentazione ha colpito ogni settore della nostra vita, fino al lavoro e allo sport, dove non esistono più posizioni e mansioni di una volta, siamo chiamati a ricoprire diversi ruoli, con le conseguenze che ciascuno di noi conosce benissimo.
Frammentazione psichica
Secondo lo psicoanalista ungherese Sandor Ferenczi, la frammentazione può essere la reazione ad un trauma, o ad un evento impensabile. In termini pop, siamo frammentati quando a tutta prima prendiamo una posizione, ma poi ci pensiamo sù, ci vengono in mente altre argomentazioni, e la nostra idea vacilla.
Un esempio straordinario di quanto siamo frammentati, è la guerra fra Russia e Ucraina. Se torniamo ai primi tempi di questa guerra, ricordiamo che l’opinione pubblica, a parte poche eccezioni, prese posizione immediata per Kiev. Su ogni organo di stampa, sui social network e davanti ai caffè, gli italiani avevano una posizione netta, chiara e incrollabile. Durò alcuni mesi, poi emerse la frammentazione, e le posizioni si polverizzarono in miriadi di atteggiamenti differenti: chi continuava a sostenere l’Ucraina, chi attribuiva le colpe della guerra alla Nato, chi appoggiava direttamente le istanze russe, sostenendo che, in fondo, fossero legittime. La difficoltà di prendere una posizione in merito a questa, come ad altre questioni, (femminicidio/patriarcato, svolta green, istruzione pubblica, e potrei continuare) denota un problema identitario, una frammentazione della nostra identità.
Seguendo il modello psicoanalitico di Ferenczi, come dicevo, potremmo sostenere che questa frammentazione sia la conseguenza di un macro trauma, o una serie di traumi, a cui non siamo riusciti a trovare un buon adattamento. Il mio mestiere non è quello storico, se non dello storico delle persone, ma posso indicare in almeno un paio di grandi cambiamenti sociali, i traumi a cui fatichiamo a fare fronte: la rivoluzione digitale e la fine del mondo a guida occidentale.
La moltiplicazione delle opportunità comunicative avvenuta in questi venticinque/trent’anni, in cui siamo passati dal primo personal computer casalingo con masterizzatore (era il non plus ultra), ai social network, definisce la perdita del rapporto con la verità, come accennavo più sopra, e lo scivolamento delle certezze identitarie.
La rivoluzione digitale è certamente traumatica per gli umani. Comporta, tanto per cominciare, l’indebolimento del rapporto con i media, e infatti siamo noi per primi ad essere coinvolti nel processo di decriptazione delle informazioni. Il web ci offre contenuti sulla base dell’algoritmo, non sulla base della veridicità, che lui per primo non è stato progettato a riconoscere. Così abbiamo sulla stessa schermata i post del Corriere della Sera e di opinionisti impreparati: la Home Page dei social network è una dichiarazione di guerra alla nostra stabilità mentale. Per non parlare, inoltre, dei cambiamenti legati alle relazioni affettive o amicali. C’è stato un tempo in cui i giochi di sguardi si facevano nel buio delle discoteche. Oggi i like sono pubblici, e se il mio amico ne avrà più di me, potrei uscirne molto male.
Il secondo punto coinvolge in maniera particolarmente profonda il nostro processo di strutturazione. Nel mondo contadino, o cittadino, del medioevo, del Settecento, e così via, non avevamo molti stimoli a metterci in dubbio. Le persone strane venivano bollate di stregoneria e relegate ai margini, i matti venivano chiusi nei manicomi, e la vita era meno complessa. All’epoca del boom americano, in cui tutti sognavamo a stelle e strisce, non eravamo (molto) frammentati. Fatta la scelta est/ovest, collocavamo noi dalla parte del bene, del giusto e del trendy, e gli altri dall’altra parte.
Al tempo attuale scopriamo che la stragrande maggioranza dell’umanità ci considera dei viziati, degli scrocconi, quando non degli approfittatori, e non vede l’ora di prendere le distanze da noi, e dal nostro modo di vivere. Anche questo è un trauma che mina le basi della nostra identità, che frantuma il nostro Sé in pezzi ignoti fra loro. E infatti sentiamo colpa per la fame nel mondo, pur sprecando molto cibo, per il cambiamento climatico, pur facendo post sui social che bruciano energia, e via di questo passo.
Quale identità? L’inganno del territorio
Come affrontare, dunque, questa frammentazione? Quale identità perseguire, a quale Sé dover dare conferma? È qui che la cosa si complica, infatti siamo portati a ricercare risposte semplici, rapide, anche per dare soluzione a problemi complessi, ma questo non è assolutamente verosimile. Un inganno molto comune è quello dell’idealizzazione del territorio di provenienza, artificio cognitivo che comporta la confusione tra il normale senso di appartenenza e la struttura dell’identità.
Il mondo dell’enogastronomia conosce molto bene la differenza tra prodotti simili provenienti da territori diversi. Un vino toscano è profondamente diverso da un vino siciliano, per profumo, gusto, corposità, ecc… ma lo è anche un vino toscano del chianti, rispetto, poniamo, ad un vino di Grosseto. Nel caso dei prodotti enogastronomici, quella terra, quel clima, quel tipo di umidità, ne determinano l’identità profonda. Per gli esseri umani le cose non possono essere assimilabili, eppure molti continuano a identificare loro stessi con il luogo di nascita. Ricordiamo tutti quei brexiters che orgogliosamente gridavano: “Io sono inglese, non britannico”, per buona pace dei fans delle Spice Girls o dei Queen, che si sentivano simili ai loro eroi, pur se italiani, francesi o tedeschi.
Gli umani nascono in un territorio, ma non da un territorio, poggiano i piedi sulla terra, ma non vi sono ancorati all’interno. Il nutrimento che prendiamo dal luogo natale, è un nutrimento anzitutto psichico, spirituale, molto più che fattuale. L’appartenenza, più che ad una regione fisica, è ad una famiglia, una rete di affetti, un complesso di dinamiche relazionali che ci hanno visto crescere.
Dante Alighieri, artista, e italiano, che dovremmo conoscere meglio, diceva: “Io che ho il mondo per patria, come i pesci hanno il mare, benché abbia bevuto all’Arno prima di mettere i denti…”. Perché Dante riteneva che la sua patria fosse il mondo? Era un grande intellettuale, non c’è dubbio, ma evidentemente sapeva, o quantomeno sentiva, che l’unità del Sé non si può fondare sugli aspetti idealizzati di un territorio di provenienza, che, per quanto magnifico, avrà anche dei difetti.
Se in seguito ai traumi che il nostro tempo ci fa attraversare, abbiamo visto frammentare la nostra identità, insieme alle certezze che da sempre ci portiamo dietro, il processo di ricostruzione deve partire da dentro di noi, da ciò che siamo, da quello che in cuor nostro avremmo voluto essere. Considerando che la traiettoria di crescita, raramente sarebbe stata diversa se fossimo nati in un’altro luogo.