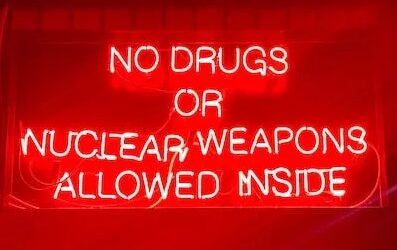Nei pazienti con comorbilità psichiatrica, di cui mi occupo da oltre un ventennio, ho visto sovente storie di vita simili, con momenti cardine che si ripetono o rassomigliano, e non soltanto per quanto riguarda l’abuso di alcolici o droghe.
Il disagio (esistenziale o psichiatrico) che questi ragazzi esprimono nel corso della loro crescita, attraversa fasi largamente, e inquietantemente, sovrapponibili. Uno degli aspetti che li lega fortemente tra loro riguarda i conflitti genitoriali a cui sono stati esposti sin da bambini, e a cui non hanno saputo adattarsi, se non sviluppando i sintomi e le caratteristiche di personalità che gli sono proprie.
Il tossicodipendente tiene unita la famiglia
Inizialmente non veniva data una grande importanza agli aspetti familiari e ambientali del paziente tossicodipendente. La sua posizione, anzi, era sovente dipinta come quella di un perfido manipolatore, una scheggia impazzita nella placida tranquillità di una famiglia, per il resto, normale. La tossicodipendenza veniva fatta risalire alle cattive compagnie, da cui questo manipolatore era stato a sua volta manipolato, plagiato, e in questa lettura si perdeva il senso profondo, non tanto dell’utilizzo occasionale delle droghe, quanto della deriva tossicomanica dei più sfortunati.
Ad un certo punto si cominciò a ritenere che il tossicodipendente tenesse legata una famiglia allo sfascio. L’alta conflittualità a cui era stato abituato, dovuta a dissidi non superati, a gravidanze inattese, o indesiderate, e cose di questo tipo, aveva segnato il paziente più di quanto egli stesso volesse ammettere, al punto da indurlo a diventare il cemento mancante nella coppia genitoriale. Una delle conseguenze della dipendenza, in altre parole, era che la preoccupazione che i genitori riversavano sul giovane, diventava l’unico punto di convergenza di una coppia ormai divisa su tutto. Si trattava di una svolta epocale, sia chiaro, da ché in precedenza, come dicevo, il tossicodipendente era visto alla stregua di Franti, il cattivo del libro Cuore.
Gli atteggiamenti vittimistici tipici di alcuni ragazzi, le loro pretese, i loro alibi, acquistavano senso quando letti nella dinamica familiare, in cui diventavano il tramite per fare superare ai genitori i conflitti, o quantomeno a toglierli momentaneamente dal loro orizzonte. Se ubi maior, minor cessat, di fronte alla salute di un figlio, tutto passerà in secondo piano.
Potremmo definire questa fase storica del nostro lavoro come quella della “ricerca di attenzioni”, ossia del tossicodipendente come un esperto nel mettere sé stesso al centro della scena. La conseguenza implicita di questo schema era che, se la coppia genitoriale si lasciava trascinare in questa dinamica, o nei ricatti che talvolta ne derivavano, lo faceva anche perché ne traeva un vantaggio: restava unita, rimandando a data da destinarsi i veri nodi della sua coesistenza.
Con il passare del tempo, tuttavia, si è visto che questa lettura, per quanto a volte corretta, non bastava, da sola, a spiegare tutti i casi di grave tossicodipendenza. Il conflitto familiare continuava ad essere presente in una serie sterminata di casi, ma la dipendenza non era sempre un sacrificio per perseguire un bene superiore. A volte era uno sfregio ad un genitore insensibile, o distratto, a volte un ricatto, oppure ancora il sostituto di un Altro (o un’Altra, come nel caso dell’eroina).
Comorbilità psichiatrica: un intreccio traumatico
La tossicodipendenza (almeno in certa parte) acquisiva un senso differente se letta nella complessità della comorbilità psichiatrica. Nella compresenza e nell’intreccio delle diagnosi (da cui il termine comorbilità), si rende impossibile stabilire con chiarezza se sia nato prima il disturbo psichico o l’abuso di droghe. Tanto è vero che i casi di spostamento delle dipendenze, sempre più numerosi con il passare degli anni, facevano pensare, più che ad una forma di adattamento al clima familiare, ad una appresa modalità standardizzata di reazione alle frustrazioni.
Nel corso del tempo, in altre parole, vedevamo pazienti dapprima schiavi dell’eroina, passati ad abusare di alcolici, forse perché la moda era cambiata, (qui pesava non tanto il ruolo delle compagnie, ma il ruolo nelle compagnie), e successivamente approdare alla cocaina. Con una dinamica incomprensibile, se vogliamo, perché chi ricerca sostanze psicotrope, non dovrebbe passare agli stimolanti. In quegli anni era facile sentirsi dire dai pazienti frasi di questo tipo: “Ho trovato nell’eroina una sostanza benefica che interagisce positivamente con il mio metabolismo. Mi calma, mi dà serenità. È il mio corpo ad averne bisogno, mi fa stare bene.” Ammetterete che lascia sgomenti scoprire che, poniamo, quindici anni dopo, chi ti ha detto queste parole pensa la stessa cosa della cocaina o del crack. Sarebbe come dire che se da studente usavo la camomilla come ipnoinducente, oggi uso il caffè: senza altra spiegazione a margine, non se ne vede il senso.
Anzi, all’osservazione, il percorso di spostamento non si arrestava: dopo la cocaina il paziente iniziava a giocare al gratta e vinci, al Superenalotto, al videopoker. Dimostrando, ancora una volta, di essere in cerca di una dipendenza, più che di una sostanza.
Veniamo al tempo presente, e alla comorbilità psichiatrica come lettura clinica e approccio terapeutico. Ancora oggi la maggior parte dei pazienti condivide una storia familiare di litigi, incomprensioni, frustrazioni. Molto spesso si tratta di coppie genitoriali sull’orlo della crisi, di divorzi litigiosi o violenti, oppure di cespugli genealogici, come nel caso, e ne abbiamo parlato molto, dei bambini adottati, affidati ecc. Storie in cui non solo sono mancati i punti di riferimento, ma i riferimenti, per quanto deboli, problematici o inaffidabili, hanno addirittura operato per delegittimarsi a vicenda.
La visione attraverso la lente della comorbilità ci porta a considerare, di conseguenza, anche l’origine ambientale e l’eredità generazionale, o trans generazionale, del disturbo, oltre ché, naturalmente, quella più prettamente psichiatrica. Ed è così che la depressione, l’angoscia esistenziale o la colpa persecutoria, (ecc…) e inevitabilmente anche la tossicodipendenza, si legano ad una storia familiare di difficoltà e sintomi non curati. La dipendenza, quindi, non appare più come lo sforzo di un bambino saggio (o egoista) che tenta di legare ciò che è ormai disunito, ma come il terminale di una storia (pluri generazionale?) di rotture traumatiche mal digerite, o non elaborate, che sono cadute in qualche modo sulle spalle (o sulla mente) del paziente.
Egli ha ammortizzato per come ha potuto le vicende distruttive, o di rigetto, che lo hanno accompagnato, o che lo hanno visto protagonista. Ha inserito la sua propensione alla dipendenza (che infatti in molti casi è anzitutto una dipendenza affettiva) in maniera stabile nelle sue relazioni significative. Ha imparato a non chiedere più di essere amato, se non a qualcosa o qualcuno che non può fare altro che deluderlo.
Nella lettura comorbile, il tossicodipendente è un ragazzo disperato troppo orgoglioso per chiedere aiuto, ma anche troppo fragile per accettare quell’aiuto, se non proveniente da chi lo ha ferito. Ma chi lo ha ferito non sa di averlo fatto, perché gravato, a sua volta, da un peso che, già in passato, non è riuscito a sostenere. Questa visione della dipendenza è, ad oggi, l’unica in grado di farci vedere davvero la commistione tra angoscia psicotica e manipolazione, tra paura dell’abbandono e autoregolazione emotiva, tra maniacalità e mancanza di autostima.
Forse non è ancora sufficiente per elaborare una strategia di approccio efficace e definitiva, ma certamente è un buon inizio. Se non altro, per cominciare a restituire a questi ragazzi la dignità di individui, dignità che la vita gli ha strappato molto prima, di quanto abbia fatto la tossicodipendenza.