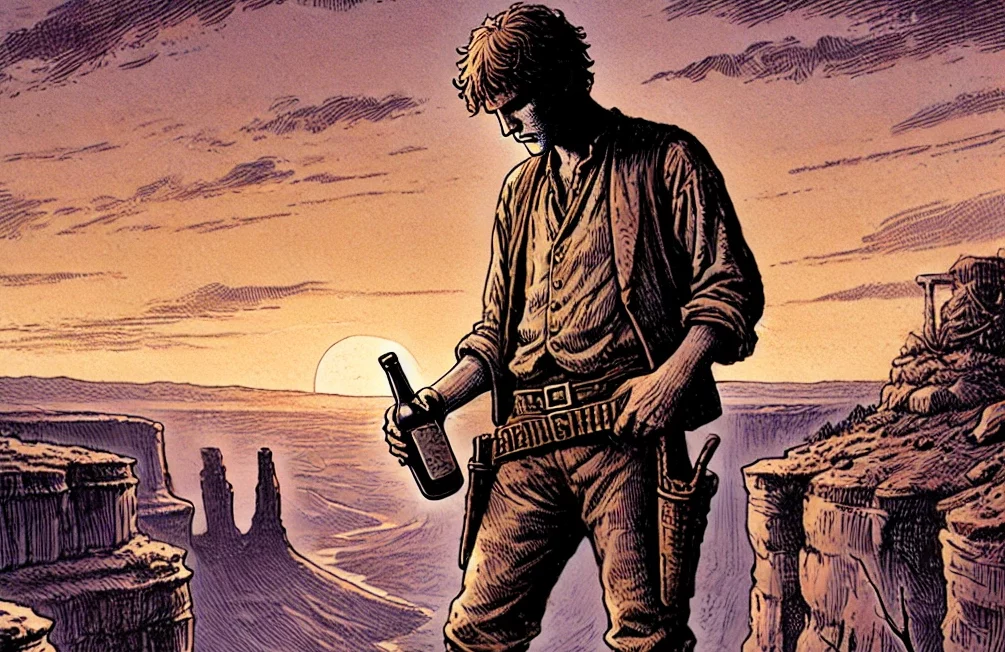Il calcio è stato a lungo lo sport più seguito dagli italiani, e per questo osservarne le dinamiche ha sempre aiutato a cogliere alcuni piccoli/grandi cambiamenti nella cultura collettiva del nostro Paese.
Tiki-Taka: il massaggio tantrico del calcio
Alcuni dati sugli ascolti delle partite dicono che la popolarità di questo sport è in calo rispetto ai decenni scorsi, ma si possono ancora fare delle considerazioni significative, soprattutto riguardo all’atteggiamento mentale con cui il pubblico guarda gli eventi. Abbiamo già detto di come la filosofia Tiki-Taka possa sfociare, quando estremizzata, in un’aggressività passiva, una specie di ostruzionismo rovesciato, dal sapore tantrico, in cui l’obiettivo non sia tanto quello di andare verso la porta, ma di irretire, se non umiliare, l’avversario.
Un altro aspetto particolarmente inquietante è la svolta narcisistica del calcio contemporaneo. Il narcisismo sta diventando un marchio tipico del nostro tempo, soprattutto se associato all’individualismo, che il modello economico di riferimento ha fatto prevalere, rispetto a tutte le forme di economia dal prefisso “sociale”.
Il narcisismo, che, come detto, di per sé non è necessariamente patologico, ha, però, quasi sempre a che fare con l’autostima e l’immagine di sé. Tanto più devo pavoneggiarmi, sminuire l’altro, evitarne l’incontro empatico, quanto più, evidentemente, ho paura di scomparire al suo cospetto, di mostrare la mia fragilità, di scoprirmi inferiore.
E il nostro presente, fatto di social network, di like, di tag nei post degli altri, è particolarmente orientato a forme di riconoscimento legate all’apparenza, più che alla sostanza.
Il risultato non conta
Ora, nel calcio contemporaneo è in atto una svolta filosofico/antropologica. La vittoria, il risultato, il conteggio dei gol fatti, sta perdendo di importanza, a scapito degli schemi, della prestazione, della qualità del gioco espresso. Non è importante vincere, ma essere apprezzati, applauditi, diciamo pure: apparire belli. Come definire questo atteggiamento, se non come narcisismo?
La svolta narcisistica è impropria, nello sport (proprio come lo è per un individuo), in quanto le regole, nella pratica, non sono certo cambiate. La vittoria nei tornei dei dilettanti e dei professionisti, nelle gare nazionali e internazionali, nelle partite amichevoli o ufficiali, viene assegnata sulla base dei gol fatti, non sulla base, per esempio, del tempo di possesso palla, del numero di passaggi, o di quello dei corner ottenuti. Quindi mistificare, e di fatto non riconoscere, questa regola, ponendovisi al di fuori, non è una strategia adattiva, ma regressiva e disadattata.
La pretesa narcisistica di essere apprezzati per il solo merito della propria presenza, senza dover fare concretamente qualcosa che valga la valutazione, o la stima, altrui, è piuttosto pericolosa. E la pretesa di essere apprezzati per quello che decidiamo noi, e non per quello che un certo contesto ci richiede, lo è ancora di più.
Credo che se da un lato dobbiamo stare attenti alla svolta narcisistica nel calcio, e nello sport in genere, come pericolosa deriva di autarchia psichica, dall’altro dobbiamo prestare attenzione al suo più pericoloso, e inquietante, sottinteso: il narcisismo dilaga, e ci ha ormai preso la mano.