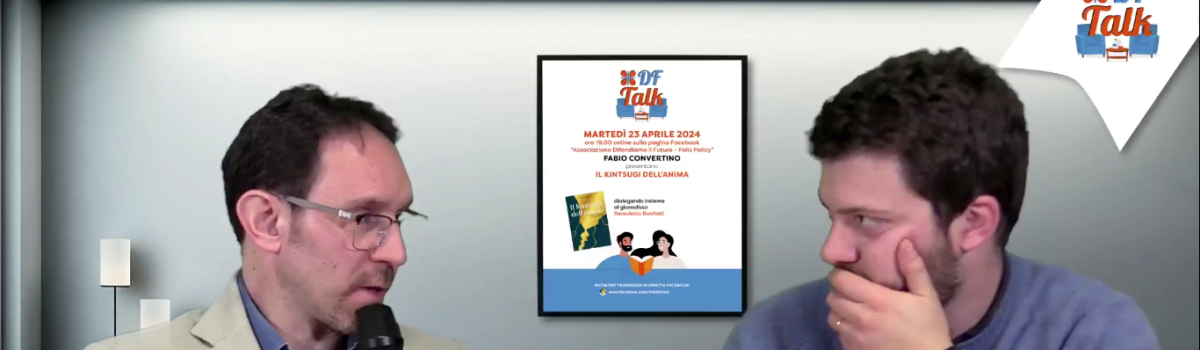Vorrei fare il punto su una figura piuttosto diffusa e, al tempo, fortemente distruttiva delle relazioni affettive, che potremmo chiamare il “bello e dannato”. Questo individuo tende a spargere intorno a sé un fascino seduttivo, a provocare premure e preoccupazioni, ma allo stesso tempo a minare l’autostima e la stabilità in chi lo avvicina, e in qualche modo se ne invaghisce. Questo particolare personaggio (useremo il maschile, ma non è solo maschio) ha la capacità innata di illudere, mantenersi equidistante, e infine di deludere l’altro, ma con la drammatica conseguenza di gettare scompiglio, a volte anche contro la sua stessa intenzione volontaria.
Sex appeal
Il bello e dannato è un individuo appetibile dal punto di vista erotico, che appare un po’ in crisi per alcune sfortunate circostanze, e che fa capire, a chi lo avvicina, che con un piccolo aiuto potrebbe uscirne più forte di prima. Le reazioni emotive di chi cade in questa trappola, di conseguenza, si mescolano alla speranza di poterlo agganciare sentimentalmente, nella fantasia di come potrebbe essere “grazie al mio aiuto”.
Sovente il bello e dannato è tormentato, cerca un equilibrio che non trova, e la tendenza a mandare in confusione gli altri, non è necessariamente dolosa. La sua sofferenza lo porta, talvolta, ad abusare di alcolici o droghe, a cercare emozioni forti, ad adottare condotte rischiose, se non autolesive. È questa inquietudine che riversa sugli altri, nella ricerca (questa sì, autentica) di un catalizzatore che riesca a calmare la sua irrequietezza.
Le sue modalità di richiesta di aiuto, tuttavia, non sono chiare. Saltano su vari livelli, da quello amicale a quello amoroso, talvolta passando da una seduttività erotica molto forte, che gli serve, tra l’altro, per controllare la situazione. La conseguenza è che chi entra in questo vortice vive una condizione borderline, ossia è molto vicino alla meta, ma anche sull’orlo di una delusione fortissima.
Vittima designata
La vittima preferita di questi soggetti è una persona che cerca delle conferme. Chi attraversa a sua volta delle difficoltà di natura relazionale, può vedere nel bello, ma raggiungibile, un riscatto alle proprie sofferenze. La vittima ha l’impressione di trovarsi di fronte ad un’occasione più unica che rara, che, se saprà sfruttare, potrà garantirgli parecchi gradi di successo: aiutare definitivamente questo individuo, conquistarlo, e sistemare, al contempo, la propria situazione sentimentale.
Questo quadro, però è tutt’altro che auspicabile, perché si basa su uno sbilanciamento di potere, e su una seduzione psicologica. Il bello e dannato, infatti, non cerca una relazione paritaria, ma un bidone in cui svuotare tutte le sue frustrazioni. Non cerca un vero aiuto, ma ha bisogno, anzitutto, di avere saldamente in mano le redini della relazione, che può indirizzare a suo piacimento in qualunque direzione. Inoltre c’è una variabile di ulteriore vulnerabilità, rappresentata dalle compagnie. Può capitare che amici o conoscenti possano gettare benzina sul fuoco, e dare consigli sbagliati, a chi è già sopraffatto da mille dubbi.
Il personaggio che abbiamo definito come bello e dannato, quindi, fa leva (involontariamente?) sulle fragilità altrui. Sono queste fragilità, pertanto, che devono essere tenute sotto controllo, quando si cade nella trappola che abbiamo delineato. Ed è proprio a queste fragilità che occorre dare risposte, prima di offrire un soccorso a chi, molto probabilmente, non ha nessuna intenzione di riceverne.