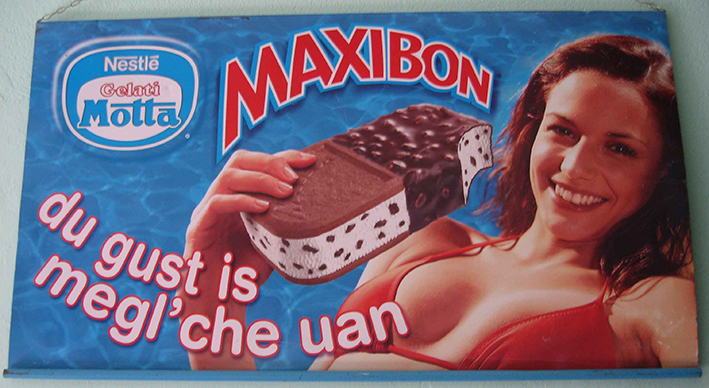Hikikomori è una modalità comportamentale prolungata di ritiro dalla vita sociale, dalle attività lavorative o scolastiche, dalle relazioni. Il termine indica tanto il comportamento, quanto gli individui che lo compiono. Inizialmente osservato in Giappone, come una forma di opposizione alla cultura nipponica tradizionale, estremamente competitiva, Hikikomori non definisce necessariamente una patologia psichiatrica: per questo è utile conoscerne le basi psichiche, al fine di porre delle contromisure più che al suo insorgere, al suo cronicizzarsi.
Giappone anni Ottanta
Verso la fine degli anni Ottanta, in Giappone, gli esperti di comportamenti giovanili hanno cominciato a osservare una forma di rifiuto della cultura classica basata sulla competizione (scuola, tecnologia, arti marziali). I giovani si chiudevano volontariamente in casa per lunghi periodi di tempo, e si dedicavano a passatempi di varia natura, quali i videogame, i fumetti manga, la meditazione. In alcuni casi il ritiro appariva particolarmente problematico: includeva, infatti, abbandono scolastico, uscita da relazioni affettive o amicali, e persino di rifiuto di intrattenere rapporti con i familiari. A questa modalità comportamentale, i giapponesi diedero nome Hikikomori, da “hiku” (tirare), e “komoru” (chiudersi, ritirarsi).
Approfondendo, con gli anni, l’indagine del fenomeno, si è poi notato che Hikikomori non era un comportamento unicamente giapponese, ma se ne trovavano varianti anche negli Stati Uniti e in Europa occidentale. Di conseguenza, possiamo fare una prima distinzione, e dire che se la polemica contro la tradizione, (tipica di molti adolescenti), è trasversale rispetto ai Paesi d’origine, allora dobbiamo separare i comportamenti patologici da quelli più tipicamente culturali/adolescenziali. Ossia, non tutte le condotte Hikikomori sono patologiche.
Gli adolescenti hanno le stesse emozioni e le stesse reazioni di tutti gli altri individui, ma amplificate per elevazione a potenza. Il rifiuto della “legge dei padri” è un passaggio tipico, e a volte molto duro, dell’adolescenza. Per individuarsi, un giovane deve anzitutto abbandonare le indicazioni che riceve dagli altri, se vuole trovare da sé la propria strada. Così, trascorrere del tempo in casa negandosi agli amici e giocando ai videogame, è cosa talmente diffusa che non basta a definire un periodo di disagio. Quando, invece, il ritiro diventa sostanziale, riguarda tutte le sfere della vita sociale e affettiva, e intacca persino il rapporto con la famiglia, possiamo cominciare a parlare di comportamento Hikikomori patologico.
Adolescenti: dal conflitto al disaccordo
Certa filosofia elegge il conflitto a origine di ogni cosa. Alcuni arrivano persino a incoraggiare il conflitto, in nome di una insopprimibile spinta a trovare il proprio posto nel mondo. Tuttavia, l’attuale situazione internazionale ci mostra i limiti di tale approccio all’esistenza. Continuando ad aprire conflitti dialettici con gli altri, in nome del mio diritto ad essere riconosciuto, corro il rischio di trovare qualcuno più testardo di me. Per questo direi che dobbiamo fare i conti con il “disaccordo”, piuttosto che con il “conflitto”.
Andare d’accordo con tutti non è immaginabile. Il disaccordo è parte integrante della relazione con gli altri, pensiamo, per fare un esempio, alla vita di coppia. Aprire conflitti su qualunque questione, significa andare alla regola del più forte, e in coppia, dove potrebbero mancare testimoni, non è una buona soluzione. Al contrario, sarebbe più funzionale accettare l’esistenza del disaccordo, e trovare la forza di starci dentro.
Nel lavoro con gli adolescenti, vedo sovente la difficoltà di raccontarsi il disaccordo. Molti ragazzi sentono di avere ragione, come se la ragione fosse un loro diritto inalienabile, e rifiutano il confronto, ad ogni livello. Concepiscono unicamente lo scontro. Lo vediamo anche nel rapporto con le istituzioni statali o religiose. Un cittadino, per capirci, può fare parte di uno Stato, o un fedele può fare parte di una confessione religiosa, pur non approvando alcuni aspetti della loro struttura organizzativa. Invece vediamo la tendenza (non solo giovanile, per la verità, ma come detto per gli adolescenti questi aspetti assumono dimensioni più eclatanti), a considerare come tutto negativo ciò che non piace, e a espellerlo dalla propria vita, o a considerarlo come un nemico giurato. Così i giovani (ma non solo) non votano più, perché “la politica non mi piace”, non vanno in chiesa perché “questa Chiesa a me non piace”, e così via. Non sono in grado di comunicare il disaccordo, o, una volta comunicato, di sostenerlo come un dato di fatto. L’unico dato di fatto che sono in grado di concepire è avere ragione, l’alternativa ad avere ragione, è il conflitto.
Convincere, conquistare, sedurre.
L’Hikikomori è un ragazzo che rifiuta di comunicare, o sostenere, il disaccordo con chi lo circonda, e si chiude in un mondo autoreferenziale di cui è il sovrano assoluto. Posto che, nei casi più gravi, questa condizione si associa a forme di sofferenza psichiatrica più profonde, resta comunque la difficoltà a sostenere un dialogo paritario con chi non viene sentito consonante. La diffidenza verso la relazione da parte dell’Hikikomori, e che lo porta all’isolamento, muove dalla sfiducia di vedere riconosciute le sue istanze, o di poterle comunque ottenere. Se vogliamo, Hikikomori è il superamento del conflitto attraverso un conflitto ancora più grande, quello dell’uscita di scena. Per certi versi mi fa pensare al Ghosting, la pratica di scomparire quando si vuole chiudere una relazione, anziché comunicarlo chiaramente.
Quale può essere, quindi, l’antidoto all’isolamento? Questi ragazzi devono recuperare la capacità di stare nel disaccordo, e capire che quello che non c’è, può essere raggiunto. Convincere, conquistare, sedurre, detto in sintesi. Nel mondo sempre più individualista, la sfiducia verso l’altro diventa cecità: se esisto solo io, non posso vedere altri che me. Se l’altro, al contrario, è per me di una qualche importanza, e soprattutto se io ritengo di avere una qualche qualità, una qualche forma di intelligenza, dovrò anche essere in grado di raggiungere ciò che non è direttamente disponibile. Nello sport, ad esempio, vediamo continuamente grandi professionisti aumentare le loro prestazioni di giorno in giorno. Non soltanto in termini fisici, ma anche nel senso della capacità strategica, della programmazione, e così via. I risultati non immediatamente disponibili, si possono raggiungere.
La tendenza, e ripeto un concetto già espresso, al di là del comportamento strettamente Hikikomori, è quella del rifiuto della competizione, in nome di un supposto diritto a vedersi riconosciuti a priori. Questo, per la maggior parte degli esseri umani non è possibile. Se non ci si vuole chiudere ad ogni forma di relazione, conviene mettere alla prova le proprie qualità, e provare a conquistare anche quei risultati che vorremmo dare per scontati.